 Scriveva Roversi in Libri nuovi Einaudi nel 1971: «Dove va il romanzo? innanzi tutto, risponderei, dove va quell’uomo. E che cosa si trascina dietro il romanzo? innanzi tutto, risponderei (con la possibile ironia), la carcassa del tempo, il lembo della sua ovvietà, il trofeo corrotto delle sue bende. Ma la domanda, in ogni senso e per la sua ripetizione, è indecente, o sorprendente, come vuole Blanchot.»
Scriveva Roversi in Libri nuovi Einaudi nel 1971: «Dove va il romanzo? innanzi tutto, risponderei, dove va quell’uomo. E che cosa si trascina dietro il romanzo? innanzi tutto, risponderei (con la possibile ironia), la carcassa del tempo, il lembo della sua ovvietà, il trofeo corrotto delle sue bende. Ma la domanda, in ogni senso e per la sua ripetizione, è indecente, o sorprendente, come vuole Blanchot.»
Bene, l’altro giorno, pensando alla giornata di ieri, giovedì 20, dove Mino Petazzini e altri amici hanno organizzato la terza edizione, al Parco Villa Ghigi di Bologna, ALLA PALMA VERDE Una lettura per Roberto Roversi, mi sono fatto un giro, come faccio sempre a dire il vero, su robertoroversi.it (grazie Antonio!) e ho trovato questo testo che avrei voluto mandare a Davide Notacon cui stiamo facendo un lavoro… Ed ecco che stamattina Davide mi invia l’incipit, poi uno dice telepatia… Be’ se non volete crederci non è una sorpresa, lo so che siete dei miscredenti.
(Nel febbraio 2017, nel progetto Un albero per te (Parco Villa Ghigi), sono stati piantati, per volontà della famiglia e di alcuni amici, un esemplare di palma di Fortune (Trachycarpos fortunei) e un melograno (Punica granatum) in ricordo di Roberto Roversi e di Elena Marcone. Là dove sono stati messi a dimora i due esemplari, si è tenuta e si terrà ogni anno una lettura di testi di Roberto Roversi, scelti e detti da suoi amici e collaboratori.)
#
Il discorso sul romanzo deve oggi ampliarsi a un discorso sull’informazione in generale (radiofonica, televisiva, giornalistica, libraria) e sulle concentrazioni in atto di gestione e produzione di mass-media.
Dove va il romanzo? innanzi tutto, risponderei, dove va quell’uomo. E che cosa si trascina dietro il romanzo? innanzi tutto, 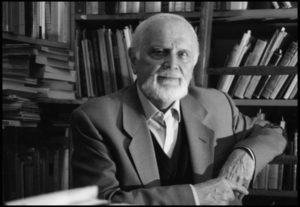 risponderei (con la possibile ironia), la carcassa del tempo, il lembo della sua ovvietà, il trofeo corrotto delle sue bende. Ma la domanda, in ogni senso e per la sua ripetizione, è indecente, o sorprendente, come vuole Blanchot. Accettando tuttavia di esercitarsi in fretta nel giuoco delle profezie o dei placidi consensi-dissensi, delle piccole ricognizioni analitiche e degli altrettanto astratti giuochi verbali – su un soggetto che, in quanto tale, da pagina uno a trecento, sembra lontano come il mare – non si può non ripetere (scolasticamente) che il romanzo, che è una invenzione della borghesia e concresce con i traffici e con i commerci di lei e si intorbida con le sue paure e canta con quel tale usignolo, seguirà come è giusto e anche prevedibile la sorte e le vicende del ventre di classe che l’ha partorito e custodito; magari accettando, come vedremo, a un certo momento e per una precisa necessità, una diversa e più ferma adozione. Cominciando a dire che il romanzo è una invenzione del cuoco (la torta più ghiotta e appariscente, veramente nuziale, che illustra la sua arte di fabbriciere) se ne può dunque stabilire, in un certo modo, le inquiete ma forse per nulla tortuose vicende.
risponderei (con la possibile ironia), la carcassa del tempo, il lembo della sua ovvietà, il trofeo corrotto delle sue bende. Ma la domanda, in ogni senso e per la sua ripetizione, è indecente, o sorprendente, come vuole Blanchot. Accettando tuttavia di esercitarsi in fretta nel giuoco delle profezie o dei placidi consensi-dissensi, delle piccole ricognizioni analitiche e degli altrettanto astratti giuochi verbali – su un soggetto che, in quanto tale, da pagina uno a trecento, sembra lontano come il mare – non si può non ripetere (scolasticamente) che il romanzo, che è una invenzione della borghesia e concresce con i traffici e con i commerci di lei e si intorbida con le sue paure e canta con quel tale usignolo, seguirà come è giusto e anche prevedibile la sorte e le vicende del ventre di classe che l’ha partorito e custodito; magari accettando, come vedremo, a un certo momento e per una precisa necessità, una diversa e più ferma adozione. Cominciando a dire che il romanzo è una invenzione del cuoco (la torta più ghiotta e appariscente, veramente nuziale, che illustra la sua arte di fabbriciere) se ne può dunque stabilire, in un certo modo, le inquiete ma forse per nulla tortuose vicende.
Un discorso, comunque avviato, sul romanzo, o una serie di domande sul romanzo, sono ancora un discorso o una serie di domande all’interno della cultura borghese; che è d’altra parte quella che stiamo giornalmente consumando (vivendo). Eppure a questo punto, proprio per precisare quanto sopra ho accennato (poiché pare esatta l’indicazione che “la borghesia non è cresciuta o migliorata, né ha preso il sopravvento la parte progressista; ma la borghesia è rimasta infine schiacciata dal capitalismo, che si è appropriato anche dei mezzi di comunicazione” – in ogni senso), direi che il o un discorso sul romanzo diventa adesso un discorso, magari generalizzato, pur partendo da una argomentazione così specifica, all’interno della cultura capitalistica; di una cultura da catena di montaggio, da cottimi e minimi garantiti, asettica e apparentemente aerata ma spietata indisponente e ricattatoria al fondo, cioè nei luoghi deputati dove tutto il potere è amministrato.
Poiché al capitalismo, nella sua fame di mercati, occorre sempre, per ogni specializzazione, produrre e mostrare (poter mostrare) una gamma di prodotti,un catalogo per ogni gusto, per ogni classe, per ogni età, per ogni stagione della vita e dell’anno, al mare, ai monti, in campagna, per distrarsi, per riflettere, per ripetere, per imparare, per distinguersi, per viaggiare con la mente o col fisico; per uscire dallo smog dell’infame città; il romanzo sarà allora progetto, sarà prodotto, sarà cosa (in piena rispettabilità e con tutti gli attributi virili o femminili); tanto più condizionato in quanto il proposito dell’autore parrà resistere opporsi contrastare. L’assimilazione e la sottomissione alle regole (a certe regole) riuscirà indolore. Il romanzo, allora, come volontà di narrare, come possibilità di narrare, come conato o conclusione di quella tale voglia, o spinta. Il romanzo, allora, come volontà di documentare, come possibilità di documentare, come estrapolazione e conclusione di quella tale voglia. Il romanzo come ricatto sentimentale, il romanzo come plagio, il romanzo amore, il romanzo erotico (esotico), il buon romanzo – quello detto rosa alle volte; il romanzo colto; il romanzo telepatico; il romanzo che esalta le tematiche o invece quello che le denigra, incerto; il romanzo classista auto-punitivo (masochista); l’uno o l’altro nevrotico, ossessivo, scaltro, ubiquo. Il romanzo che si consuma in se stesso, divorato dalle proprie parole; o il romanzo con la lingua del romanzo, il saltarello grammaticale, il suo fragile
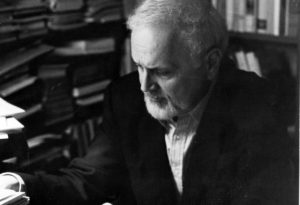
rondò, la sua densità gergale (o verbale), il regno della crusca. Il romanzo gregoriano e mistico. Quello fantascientifico; il romanzo sportivo.
Insomma, quelli che sono subito in orbita (all’apparenza) per gli anni duemila e gli altri casarecci, quieti fra le pastorelle (vicino a quel rio), per la luna del mese. Ma proprio in quanto tale, e così sezionato e distratto; proprio per quella matrice sopradescritta (un utero di ferro l’ha custodito) egli ha, come i gatti, sette vite; sorge-risorge ancora dalla cenere. Il capitalismo (che si prepara a menare per un poco la danza) ha bisogno fra altre mille cose anche di questo strumento, così come ha bisogno, per esempio, di esercitare in pubblico una propria carità; in entrambi i casi, sia pure da angolazioni diverse e sia pure con motivazioni assai dissimili, esso scarica le raffiche del proprio programmato concerto di morte (proprio con l’amministrazione di questi mezzi repressivi); e, insieme, scarica la zavorra non troppo peregrina della propria falsa coscienza; e per il colto e per l’inclita si aiuta ad assumere quella maschera di fervore che lo salva da tutte (o in parte) le quotidiane sconcezze.
Sappiamo e leggiamo, abbiamo letto, che la letteratura (dunque anche il romanzo per essa) da molto tempo e a cicli periodici – per una sorta di commedia in cui si mescolano, avvertiti o inavvertiti, i calcoli più sottili – suole fingersi disposta a una morte imminente; secondo gli aruspici avendo già predisposto il proprio rituale funebre, prodromo di un affossamento rapido definitivo. “L’arte è per noi cosa passata”, o per la penna del Tenca nell’anno 1845: “del presente è d’uopo disperare, e rassegnarsi mestamente a veder perire la nostra letteratura”. Ma è anche vero che a ogni stagione il distacco è rimandato e gli spettatori – quelli che vogliono – assistono a ricuperi soltanto in apparenza sorprendenti, nel senso di una disponibilità subito risonante e subito vitale (anche se la vitalità, questa vitalità non è poi integra e corposa ma piuttosto una funzione astuta di essa).
Dunque in riferimento a questo oggetto – cioè al romanzo in quanto tale – tutto appare incerto ma tutto appare certo e definitivo; tutto sembra devastarlo e scorrergli via in fretta, bruciato dall’indifferenza di una società che sembra trovi altrove i canali rapidi di informazione e di intrattenimento; bruciato dalla stanchezza di questa società (e alle volte è soltanto una stanchezza apparente), dalle sue nevrosi, dai suoi ossessivi e possessivi interessi; e nonostante questo continuano a passare davanti agli occhi come un fiume come una lava come una ordinata catena come il rimorso – o, se si vuole, come un residuo vegetale – un carosello di fogli che coprono le piazze stravolgendole simili a una forsennata nevicata. Pare che ogni cosa debba restare sommersa; anche il malumore.
L’ambiguità del romanzo, inteso come forma diretta di pressione culturale e come ulteriore salvaguardia di interessi costituiti, è confermata dalla propria ambivalenza che gli consente e anzi in questo senso lo legittima e sospinge a “riflettere sia la fase costruttiva che quella disgregatrice della società contemporanea” e a aiutarci a spiegare, o spiegarci addirittura come “funzioniamo collettivamente nella società” (secondo Bergum); a registrare dunque anche i contrasti sociali, non altrimenti che una televisione scritta. Poiché la cultura borghese; meglio, la cultura gestita dal capitalismo, ha scoperto in questi ultimi anni la necessità di una partecipazione diretta non solo alla elaborazione di tutti i problemi, ma anche alla loro scoperta – scoperta che una volta era affidata, in una delega disinteressata e infastidita, alle avanguardie.
A tutti i problemi, ho detto, siano quelli del consenso che quelli del dissenso; e soprattutto ha potuto e saputo valutare i vantaggi 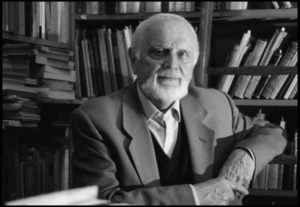 di ogni genere – ai fini della propria egemonia – che l’utilizzazione e la strumentalizzazione di tale problematica comporta. Una volta, insomma, c’era uno spazio esiguo per la libertà di un artigianato risentito (e attivo); oggi non più. Per quanto ho detto prima, basti il rapido raffronto – giornalistico – con la scoperta “che stiamo distruggendo Torino”, pubblicizzata dalla grande gazzetta e dopo vent’anni di scempi inauditi al nord e al sud; o la scoperta (non saprei definirla se più tragica o comica – nel senso della morte) dell’ecologia da parte delle dirigenze politico-amministrative.
di ogni genere – ai fini della propria egemonia – che l’utilizzazione e la strumentalizzazione di tale problematica comporta. Una volta, insomma, c’era uno spazio esiguo per la libertà di un artigianato risentito (e attivo); oggi non più. Per quanto ho detto prima, basti il rapido raffronto – giornalistico – con la scoperta “che stiamo distruggendo Torino”, pubblicizzata dalla grande gazzetta e dopo vent’anni di scempi inauditi al nord e al sud; o la scoperta (non saprei definirla se più tragica o comica – nel senso della morte) dell’ecologia da parte delle dirigenze politico-amministrative.
Il punto è che il potere può auto-accusare se stesso, può auto-punirsi; può auto-condannarsi; e ormai senza nemmeno il fastidio, di un tempo, di compiere le piccole operazioni di resezione dal proprio corpo delle escrescenze malate. Fermo e indifferente, egli può continuare a portare in groppa le proprie vergogne; basterà raccontarle, descriverle, cantarle; poiché ormai ogni atto pubblico, quale che sia, può tradursi in vantaggio, in una moneta;in quella tale cambiale. Il potere dunque gestisce adesso anche il tribunale delle proprie colpe; si ammonisce, si ferisce, si perseguita, si assolve. Appare impietoso con sé ed è invece perso in una girandola di scaltrissime manomissioni.
All’inizio degli anni Cinquanta, mentre nella grande fabbrica orgoglio della nazione, si impostavano le catene (montaggio- prigione) per dare il via all’operazione macchina utilitaria- strade ecc., il romanzo si impegnò a descrivere la condizione di sordida ignominia delle classi subalterne appaltando al sentimento (che generalizzava e piangeva) un giudizio politico preciso nella descrizione dei lager nuovi che si apprestavano. Si lamentava la miseria immediata, non il progetto dell’immediato ergastolo a cui si condannava la condizione dell’uomo. All’inizio degli anni Sessanta, proprio nel momento della seconda ristrutturazione capitalistica, nel momento della riconversione tecnologica il romanzo si impegnò a descrivere questa condizione di trasformazione programmata, dell’inurbamento caotico, della parcellizzazione del lavoro contadino e delle concentrazioni metropolitane – restando l’uomo come un oggetto o soggetto di pietà, dunque subalterno in questo grande giuoco del mondo, e non protagonista. Il romanzo si dispose infatti ad aggredire e frantumare una lingua di marmo e le linee di un montaggio narrativo che apparivano obsolete e infide.
Libri Nuovi, Periodico Einaudi, n. 9, luglio 1971.
