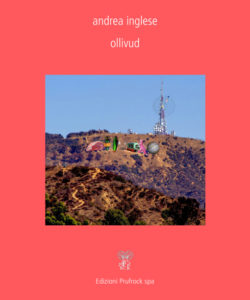 Gianluca Garrapa: Ollivud: scritto come si pronuncia, pare che del suono abbiamo solo la forma. Quello che è, quello che ascolto. Come le scene di questo scritto: è linguaggio che crea situazioni perturbanti, capricci: “Sono capricci. Proprio adesso avete il crollo nervoso, tutti assieme!?” (Quiete). Senza abortire alcunché, senza conflitto, una scrittura, la tua prosa, esattamente all’opposto del bello scrivere lineare e prevedibile: È così che termina un film drammatico, umanista, con il lancio meditato e selvaggio del bicchiere, la frantumazione accurata dello specchio, senza il conforto facile, ma la previsione sì, la completa previsione dell’incidente (Bicchiere), l’enunciato è l’enunciazione. La visione è lo sguardo. Direi che la scrittura si muove in direzione contraria a quella che vorrebbe la parola come morte simbolica della cosa: era il solito film contro l’ambientazione sociale, contro la psicologia dei personaggi, contro una storia intellegibile. (Camminata), non c’è metafora e tutto il detto è detto e questo è tutto. In che direzione si muove la tua scrittura nel viaggio tra la prosa di Ollivud e gli esiti del tuo precedente romanzo Parigi è un desiderio? E perché hai desiderato scrivere Ollivud?
Gianluca Garrapa: Ollivud: scritto come si pronuncia, pare che del suono abbiamo solo la forma. Quello che è, quello che ascolto. Come le scene di questo scritto: è linguaggio che crea situazioni perturbanti, capricci: “Sono capricci. Proprio adesso avete il crollo nervoso, tutti assieme!?” (Quiete). Senza abortire alcunché, senza conflitto, una scrittura, la tua prosa, esattamente all’opposto del bello scrivere lineare e prevedibile: È così che termina un film drammatico, umanista, con il lancio meditato e selvaggio del bicchiere, la frantumazione accurata dello specchio, senza il conforto facile, ma la previsione sì, la completa previsione dell’incidente (Bicchiere), l’enunciato è l’enunciazione. La visione è lo sguardo. Direi che la scrittura si muove in direzione contraria a quella che vorrebbe la parola come morte simbolica della cosa: era il solito film contro l’ambientazione sociale, contro la psicologia dei personaggi, contro una storia intellegibile. (Camminata), non c’è metafora e tutto il detto è detto e questo è tutto. In che direzione si muove la tua scrittura nel viaggio tra la prosa di Ollivud e gli esiti del tuo precedente romanzo Parigi è un desiderio? E perché hai desiderato scrivere Ollivud?
Andrea Inglese: Ollivud si pone per certi versi agli estremi opposti di Parigi è un desiderio. In Parigi è un desiderio ho cercato di convogliare le mie differenti pratiche di scrittura (saggistiche, satiriche, poetiche, diaristiche, ecc.) dentro la forma fluida del romanzo, che è comunque una forma “riconoscibile”, una forma che implica un certo compromesso comunicativo con il lettore. E, lo dico per inciso, venendo dalla poesia questo compromesso comunicativo è proprio ciò che m’interessava. In Ollivud, invece, non ho voluto cercare nessun compromesso comunicativo, per portare all’estreme conseguenze, da un lato, una sorta di critica della narrazione cinematografica – nei racconti brevi della prima sezione – e dall’altro per giocare in modo radicale e centrifugo con quella pluralità di scritture, che nel romanzo ho voluto amalgamare – nella seconda sezione, dedicata a un attraversamento psichedelico di 2001 Odissea nello spazio di Kubrick. Infine, ho scritto Ollivud perché mi piacerebbe trovare un lettore per questo tipo di scrittura, un lettore che si diverta con me a passare in contropelo stereotipi narrativi e ideologici diffusi dalla grande  macchina cinematografica e televisiva. Non so, però, se tale lettore esista. Non è certo quello del romanzo, ma neppure quello della poesia. Magari qualche amante della poesia sperimentale, o delle scritture di ricerca, come usiamo dire oggi. Ma sul piano dell’invenzione letteraria è un terreno in gran parte vergine, quello in cui ho messo piede con le prose di Ollivud. Da noi quello che ci lavora in modo più sistematico negli ultimi anni è probabilmente Marco Giovenale, con libri come Quasi tutti e Il paziente crede di essere; altri nomi che mi vengono in mente, come Gherardo Bortolotti o Manuel Micaletto, vengono anch’essi, seppure con grande riluttanza, da regioni più prossime alla poesia che alla narrativa. Comunque lascio agli altri di individuare più o meno plausibili parentele.
macchina cinematografica e televisiva. Non so, però, se tale lettore esista. Non è certo quello del romanzo, ma neppure quello della poesia. Magari qualche amante della poesia sperimentale, o delle scritture di ricerca, come usiamo dire oggi. Ma sul piano dell’invenzione letteraria è un terreno in gran parte vergine, quello in cui ho messo piede con le prose di Ollivud. Da noi quello che ci lavora in modo più sistematico negli ultimi anni è probabilmente Marco Giovenale, con libri come Quasi tutti e Il paziente crede di essere; altri nomi che mi vengono in mente, come Gherardo Bortolotti o Manuel Micaletto, vengono anch’essi, seppure con grande riluttanza, da regioni più prossime alla poesia che alla narrativa. Comunque lascio agli altri di individuare più o meno plausibili parentele.
G.G.: Ollivud raccoglie le prose ‘cinematografiche’ e Quando Kubrick inventò la fantascienza. Le prose fanno vedere esattamente quel che dicono, le parole non, direbbe qualcuno, uccidono le cose, e le cose parlano da sé, esattamente come le immagini dovrebbero essere visione: tutta roba alfabetizzata, verbale, tutta roba semantica, da pigiarsi nelle orecchie, la retina è morta…, scrivi citando Kubrick. Che rapporto hai con l’immagine?
A.I.: Scherzando, ho detto che Ollivud è una sorta di manrovescio indirizzato al mondo dell’immagine, particolarmente quella cinematografica, che mi ha non poco malmenato nel corso dell’esistenza. Diciamo: è il calcetto negli stinchi, che ho cercato di refilare all’industria cinematografica, vero energumeno che di solito ci aggredisce quanto e quando vuole lui. Tornando alla tua domanda, ho con le immagini il rapporto che hanno tutti: le guardo quasi sempre come se non ci fosse dietro nulla, come se non fossero l’esito di  un processo produttivo estremamente complesso, parlo delle immagini di un film, o di una trasmissione televisiva, o di un cartellone pubblicitario. Poi le guardo, come tutti, perché è facile guardarle, perché mi pongono in una piacevole e irresponsabile postura passiva, di fruitore perfetto, che riceve tutto senza fare nulla. Ad esempio, quando mi faccio di tanto in tanto un’oretta di zapping di fronte alla tele. Poi, qualche volta, incontro anche immagini forti. Penso, in questo caso, al film di Kubrick. E qui accadono due cose. La prima è che queste immagini resistono. S’impiantano nella mente, e ci rimangono per un tempo indefinibile, ma lungo. Insomma, non se ne vanno via all’istante, come accade con i film standard, che scivolano nell’oblio con i loro significati prevedibili. In altri termini, si vede qualcosa ma non si sa quello che si vede. Quando questo accade, si può sicuramente parlare di una riuscita artistica, estetica, dell’opera visiva (cinema, pittura o altro). Di fronte a ciò, e vengo al secondo punto, chi scrive si trova coinvolto in una sfida interessante. D’un tratto, ho voglia di dire quello che sto vedendo, ho la necessità di esplorare ed elaborare per iscritto quello che ho visto, dal momento che non saprei dire, nell’immediato, quello che ho veramente visto. L’immagine, qui, sollecita una postura inventiva, non solo esegetica. Non si tratta neppure di interpretare semplicemente, ma di fare con le parole qualcosa di nuovo, di diverso, a partire da certe immagini.
un processo produttivo estremamente complesso, parlo delle immagini di un film, o di una trasmissione televisiva, o di un cartellone pubblicitario. Poi le guardo, come tutti, perché è facile guardarle, perché mi pongono in una piacevole e irresponsabile postura passiva, di fruitore perfetto, che riceve tutto senza fare nulla. Ad esempio, quando mi faccio di tanto in tanto un’oretta di zapping di fronte alla tele. Poi, qualche volta, incontro anche immagini forti. Penso, in questo caso, al film di Kubrick. E qui accadono due cose. La prima è che queste immagini resistono. S’impiantano nella mente, e ci rimangono per un tempo indefinibile, ma lungo. Insomma, non se ne vanno via all’istante, come accade con i film standard, che scivolano nell’oblio con i loro significati prevedibili. In altri termini, si vede qualcosa ma non si sa quello che si vede. Quando questo accade, si può sicuramente parlare di una riuscita artistica, estetica, dell’opera visiva (cinema, pittura o altro). Di fronte a ciò, e vengo al secondo punto, chi scrive si trova coinvolto in una sfida interessante. D’un tratto, ho voglia di dire quello che sto vedendo, ho la necessità di esplorare ed elaborare per iscritto quello che ho visto, dal momento che non saprei dire, nell’immediato, quello che ho veramente visto. L’immagine, qui, sollecita una postura inventiva, non solo esegetica. Non si tratta neppure di interpretare semplicemente, ma di fare con le parole qualcosa di nuovo, di diverso, a partire da certe immagini.
G.G.: (tra l’altro Ollivud è corredato da due fotografie: all’inizio delle prose in prosa cinematica, e all’inizio dei capricci, mi pare sia uno dei fotogrammi iniziali di 2001: Odissea nello spazio, le scimmie che hanno ‘scoperto’ la violenza e si avviano verso la conquista della civiltà…)
E però un orizzonte di comprensibilità stringe il senso delle sceneggiature in prosa, penso a La Montagna Sacra di Odoroschi (scritto come si pronuncia, a questo punto) ma anche ai montaggi surrealisti e perché no, anche al teatro di Grotowski (forse per quella santità laica, non saprei, non comprendo l’associazione d’idee… o forse sì, era per il discorso intorno al sogno di John Dio…), un orizzonte di senso che vede opposti materia e spirito, lungo un continuum caotico che va dal preumano al postumano (come nel film di Kubrick che prendi in esame). Nel mezzo del camminamento civiltoso-schifiltoso, impantanato in quest’odierna deriva automica (noi automi), omologazione virtuale, c’è un reale contraffatto, mi pare: soltanto le migliori menti del nostro tempo possono sperare di districarsi dai problemi posti dall’idiozia di un automa. Dunque: che differenza c’è tra l’immagine e la parola, domandone, me ne rendo conto, ma stringiamo l’ambito, piano americano, primo piano, primissimo piano: oggi: che tipo di parola e che tipo di immagine possono avere una valenza davvero creativa, artistica nel bailamme di scritture-selfie e selfie-fotoromanzistici?
A.I.: Forse mi stai domandando in che modo io possa considerare, nelle cose che faccio – in genere libri –, il rapporto tra immagine e parola, ossia mi stai chiedendo come io, scrittore, includa o lavori anche con le immagini. In effetti, io amo molto fotografare e persino filmare. Sono quindi un tipico caso di fotografo amatore, che avendo una macchinetta digitale può anche permettersi di filmare. (Uso ancora un apparecchio specifico per fare questo, dato che non posseggo uno smartphone.) Le immagini fanno quindi parte del mio archivio, del materiale grezzo che posseggo, come gli appunti “analogici” scritti sui quaderni. Ed entrano in gioco in vario modo, anche solo accompagnando in maniera indiretta, fortuita, la scrittura dei miei libri. Quindi sono naturalmente propenso a mischiare immagini, soprattutto fotografiche, e scrittura. Ma sono, in realtà, propenso a mescolare scrittura e qualsiasi altra cosa: immagini video, musica, azioni sceniche, solitamente  attraverso collaborazioni con altri artisti. Per quanto riguarda i miei libri, l’immagine fotografica, seppure in modo solitamente discreto, è quasi onnipresente. E riveste un ruolo ambiguo, giocando tra diversi piani: quello puramente ornamentale – il più arcaico e inattuale –, quello illustrativo, che è anche il più standard, e quello concettuale, in cui l’immagine è disgiunta dalla parola, e funziona non per rafforzamento ma per interferenza, disturbo, disseminazione. Ci sono immagini fotografiche, riproduzioni di dipinti o stampe in Prati (2007 e 2009), Commiato da Andromeda (2011), La grande anitra (2013), I miei pezzi nel volume collettivo Ex.it (2013), Prese su Rembrandt nel volume collettivo Nell’occhio di chi guarda (2014), Parigi è un desiderio (2016) e, appunto, Ollivud (2018). Discorso a parte, si potrebbe fare forse per Quando Kubrick inventò la fantascienza, nella sua prima versione, uscita nel 2011 per La Camera Verde, e per Un’autoantologia Poesie e prose 1998-2016 (2017). In questi due casi, la presenza d’immagini fotografiche è più consistente e abbiamo a che fare con delle serie, l’una che amplia e moltiplica il piano semantico del testo, in Kubrick, e l’altra, intitolata Pagine, che inserisce nell’antologia di testi uno specifico lavoro fotografico con un carattere autonomo. Infine, vi è il lavoro fatto, e ancora in corso, con il sito Descrizione del mondo. In questo progetto, che vuole essere una sorta di laboratorio aperto in cui testo e archivio si confrontano, parola e immagine sono in qualche modo fissate nel loro dialogo costitutivo. Si vorrebbe fare un’archeologia del rapporto tra immagine e scrittura, anche a partire da singoli testi. In altri termini, indagare e mostrare come certi documenti, e in particolar modo quelli iconografici, entrano nel nostro progetto d’invenzione poetica e artistica.
attraverso collaborazioni con altri artisti. Per quanto riguarda i miei libri, l’immagine fotografica, seppure in modo solitamente discreto, è quasi onnipresente. E riveste un ruolo ambiguo, giocando tra diversi piani: quello puramente ornamentale – il più arcaico e inattuale –, quello illustrativo, che è anche il più standard, e quello concettuale, in cui l’immagine è disgiunta dalla parola, e funziona non per rafforzamento ma per interferenza, disturbo, disseminazione. Ci sono immagini fotografiche, riproduzioni di dipinti o stampe in Prati (2007 e 2009), Commiato da Andromeda (2011), La grande anitra (2013), I miei pezzi nel volume collettivo Ex.it (2013), Prese su Rembrandt nel volume collettivo Nell’occhio di chi guarda (2014), Parigi è un desiderio (2016) e, appunto, Ollivud (2018). Discorso a parte, si potrebbe fare forse per Quando Kubrick inventò la fantascienza, nella sua prima versione, uscita nel 2011 per La Camera Verde, e per Un’autoantologia Poesie e prose 1998-2016 (2017). In questi due casi, la presenza d’immagini fotografiche è più consistente e abbiamo a che fare con delle serie, l’una che amplia e moltiplica il piano semantico del testo, in Kubrick, e l’altra, intitolata Pagine, che inserisce nell’antologia di testi uno specifico lavoro fotografico con un carattere autonomo. Infine, vi è il lavoro fatto, e ancora in corso, con il sito Descrizione del mondo. In questo progetto, che vuole essere una sorta di laboratorio aperto in cui testo e archivio si confrontano, parola e immagine sono in qualche modo fissate nel loro dialogo costitutivo. Si vorrebbe fare un’archeologia del rapporto tra immagine e scrittura, anche a partire da singoli testi. In altri termini, indagare e mostrare come certi documenti, e in particolar modo quelli iconografici, entrano nel nostro progetto d’invenzione poetica e artistica.
G.G.: La suddivisione in tre tipi psicologici a partire dagli oggetti è molto interessante: che cosa davvero vi interessava da bambini: 1) TRENINI, 2) DINOSAURI, 3)PIANETI. Hai delineato il fantasma, come ognuno di noi si rapporta all’oggetto del proprio desiderio. Il tuo oggetto sono i pianeti, le astronavi, lo spazio, l’astronomia: che legame potrebbe esistere tra la tua prosa e… l’astronomia? A proposito, la classificazione molto ironica dei tipi kubrichiani-inglesiani è all’inizio del terzo Intervallo, una delle sezioni che compone la seconda parte di Ollivud: ci racconti come hai strutturato questa seconda parte calderonico-saggistica?
A.I.: La seconda sezione di Ollivud, ossia Quando Kubrick inventò la fantascienza. 4 capricci su 2001, corrisponde a uno dei miei libri più costruiti e al tempo stesso più anarchici. La costruzione era dettata da motivi sia estrinseci, come le quattro parti del film (Kubrick, Trama, Il bambino metafisico, La scimmia infaticabile), e più in generale il ruolo strategico che il numero 4 svolge in 2001, sia intrinseci, legati cioè ai temi dominanti che avevo circoscritto nel mio “orbitare” intorno al film. Vi erano poi gli Intervalli, che costituivano delle grandi digressioni oppure degli sviluppi narrativi o saggistici paralleli. Infine la Coda, che rimandava ancora una volta a elementi compositivi ma anche figurativi, ossia la coda vera e propria delle scimmie. Ogni capitolo era poi costruito mescolando versi e prosa, con una predominanza per blocchi di prosa giustapposti, secondo la logica erratica del montaggio. I versi, poi, quando c’erano, fungevano non da espressione  lirica, ma mettevano in forma brani di saggio critico, di diario o di narrazione autobiografica. In questo spregiudicato gioco su e attraverso i generi mi aiutò una scrittrice francese, che avevo da poco scoperto, Nathalie Quintaine. In ogni caso, mentre lo stavo scrivendo, avevo la sensazione di godermela troppo e di fare qualcosa di strambo. Oggi, a distanza di sette anni, l’operazione mi sembra del tutto familiare e leggibile. Non saprei se altrettanto familiari e leggibili sono i racconti della prima sezione; io ovviamente lo spererei, anche perché più “pop” di Hollywood si muore…
lirica, ma mettevano in forma brani di saggio critico, di diario o di narrazione autobiografica. In questo spregiudicato gioco su e attraverso i generi mi aiutò una scrittrice francese, che avevo da poco scoperto, Nathalie Quintaine. In ogni caso, mentre lo stavo scrivendo, avevo la sensazione di godermela troppo e di fare qualcosa di strambo. Oggi, a distanza di sette anni, l’operazione mi sembra del tutto familiare e leggibile. Non saprei se altrettanto familiari e leggibili sono i racconti della prima sezione; io ovviamente lo spererei, anche perché più “pop” di Hollywood si muore…
(calderonica perché è davvero un calderone di forme, una scrittura pluriforme, saggio, poesia, memoria, esegesi, filosofia, critica sociale, critica psicoanalitica.)
G.G.: A proposito di prosa: che idea ti sei fatto della scrittura in rapporto alla politica? intendo dire: quando il linguaggio lo torciamo in maniera anti-narrativa e anti-lineare, è sempre un guasto che si crea nel sistema, una falla nel potere linguistico costituito, il primo gradino… in qualche modo la filmografia onirica di Lynch è anti-narrativa… pardon: forse meglio dire che non si oppone a alcun sistema, ma ne crea uno nuovo. Ecco, preferisci la scrittura anti-qualcosa o un diverso modo di intendere la scrittura, una qualcosa-scrittura non identificata, scrittura-ufo, per restare nella fantascienza?
A.I.: Su scrittura e politica ho parlato spesso e devo aver anche detto abbastanza cazzate. Invece sulla scrittura anti, sono decisamente contro. Non m’interessa né l’anti-quello né il post-quello. È una vecchia storia. Perché sobbarcarmi il termine che cerco di eludere o scavalcare? La scrittura non identificata, la scrittura ufo, m’interessa di più, perché rimanda allo sforzo, e all’eventuale possibilità, di identificarla. L’arte ci ha mostrato in continuazione questa vicenda: cose strambe che diventano familiari, cose difficili che diventano semplici, cose oscure che diventano chiare. Naturalmente, è utile utilizzare categorie, utile ma quasi sempre pericoloso, soprattutto sul piano artistico. Lo si fa in quanto critici, per opportunità conoscitive, lo si fa come autori, per opportunità autopromozionali. Oggi il problema non mi sembra quello di esprimere una forma o mettere in atto un procedimento che sia al passo coi tempi, liberandosi di eredità morte o sorpassate. Mi sembra semmai che il Novecento trascorso, con tutta la sua dose di avanguardie e neo-avanguardie, di modernismi e post-modernismi, si presenti a noi come un cantiere, in cui una grande quantità di progetti, percorsi, operazioni sono suscettibili di essere riprese, approfondite, sviluppate all’altezza dei problemi e dei conflitti odierni.
G.G.: … Uno sfondamento dello specchio narcisistico (Zampe): mi pare questo il presupposto della tua scrittura, descrittura mi piace definirla, o scrittura desiderante. La prosa è imprevedibile e ogni significante rimanda al successivo, metonimico, desiderante appunto, rinvia al successivo e sullo stesso piano che non rinvia metaforicamente a altro, è scrittura non sintomatica. Per questo mi stupisce la seconda parte, interpretativa. Le scimmie, non quelle sulla schiena di Burroughs, seppure i riferimenti alla sostanza M (per citare quel capolavoro della fantascienza che è stato l’Oscuro  Scrutare di P. K. Dick portato in film attraverso la tecnica rotoscopica) non manchino, ma le scimmie: raccontaci questo animale che dunque siamo: come mai ti ha così entusiasmato? È colpa di Kubrick?
Scrutare di P. K. Dick portato in film attraverso la tecnica rotoscopica) non manchino, ma le scimmie: raccontaci questo animale che dunque siamo: come mai ti ha così entusiasmato? È colpa di Kubrick?
A.I.: Qui s’inserisce una mia piccola operazione documentaria e, nello stesso tempo, inquinante. Ho creato un’interferenza attiva tra le celebri scimmie di 2001 di Kubrick, il film che ha riscattato attraverso un approccio intellettuale e autoriale la fantascienza, e Il pianeta delle scimmie di F. J. Schaffner (da un testo del francese Pierre Boule) che ha rappresentato la svolta intraterrestre della fantascienza, e di una fantascienza politica tutt’ora attuale, ossia attraversata dal conflitto sia di classe che ecologico. Ebbene, non è forse un caso che le scimmie, nelle loro differenti “divise” allegoriche, siano presenti in due film cruciali proprio nell’anno 1968 (rivoluzione di portata mondiale, ricordiamolo). La scimmia è allora portatrice di maniere d’essere che la civiltà idiota – permettimi quest’autocitazione – ha espulso da sé, per rimozione o semplice repressione.
G.G.: La varietà del tuo libro, non lo rende un varietà, però è divertente il modo in cui tratti tematiche metafisiche e in qualche modo la pulce nell’orecchio filosofico di chi legge la metti, così come, allo stesso diverso modo, il film di Kubrick destabilizza il senso e muove lo spettatore verso varchi di ulteriore riflessione: io considero poetico e comico (l’amore è comico), due facce della stessa medaglia che è il desiderio, lacaniano, in quel senso, e Lacan me lo hai rammentato quando scrivi della sequenza numerologica del numero 4: Carolyn Geruld, nella sua analisi strutturalista del 1978, individua come cifra strutturante del film il numero 4 (Intervallo), 4 è anche molto presente nella psicosi logica di Lacan. Ma non è questo il punto: volevo sapere proprio il tuo sguardo filosofico, la tua idea che possa unire scrittura, cinema, scimmie e dio.
A.I.: Non è l’idea filosofica che a me interessa in questi casi, ma le idee – molteplici e intrecciate – narrative che da un tale film, da una tale struttura, posso far emergere e sviluppare. E queste sono la sostanza stessa del libro.
G.G.: Queste cose impossibili, poi, arrivano presso di loro […] è una virtù indipendente dai quasi morti, e risiede a fondo nel sistema, è una tipica virtù sistemica […] (Acquisto finale) riguardo sempre la politica, la cura della cosa pubblica, quali sono le tue paure? tu come scrittore e poeta e critico cinematografico. La scrittura e la poesia e il cinema sono il riflesso della società: credi ci potrà essere ancora spazio per la, o una, rivoluzione?
A.I.: Lasciamo perdere la rivoluzione, che presupponeva la lotta finale, e il partito di tutti i proletari uniti, ecc. In secondo luogo, non è solo questione di credenza e di opinione personale o collettiva. L’organizzazione del mondo attuale continua a perpetrarsi attraverso costi umani e naturali spaventosi. Questi costi implicano concretamente enormi quantità di dolore evitabile, ossia dolore che una diversa forma di organizzazione sociale potrebbe sanare o diminuire. Sui costi naturali, non c’è granché da dire, dal momento che da un po’ di anni a questa parte è diventato il tema del giorno, e lo resterà con certezza per lungo tempo, almeno quanto è rimasto attuale il tema dell’uguaglianza di classe, tra proletari e capitalisti. L’idea quindi dell’importanza di una critica radicale delle istituzioni e della possibilità di trasformare i modi di riproduzione sociale degli esseri umani, è per me strettamente intrecciata con la scrittura. Quest’ultima, infatti, racconta e nomina il mondo sempre a partire da un luogo eccentrico, che è quello del possibile domani. Se non credessi a un futuro diverso, dove una o più rivoluzioni si siano realizzate, mi mancherebbe uno spazio estetico d’invenzione.
G.G.: Ultima considerazione: ho l’impressione, leggendo il tuo lavoro, che la poesia e la fantascienza siano degeneri, più che generi, insomma, assimilabili all’aspetto desiderante e anarchico del linguaggio (anche se possiamo avere le versioni commercial-goderecce della poesiola e del fimino rassicurante e narcisistico…) e leggibili come protesi dell’universo inconscio e onirico di chi decide di produrre il proprio desiderio scritto o filmico: che ne pensi?
A.I.: Penso quello che già pensava Kubrick negli anni Sessanta, quando davvero la fantascienza era considerato un sottogenere commerciale e un po’ idiota. Penso non soltanto che, attraverso di essa, si possano fare tante cose diverse, anche meditazioni sul destino della specie umana, e cose simili, ma penso che essa faccia parte delle forme del cantiere novecentesco di cui ancora si può trarre molto. Basterebbe leggersi Quando arrivarono gli alieni di Gherardo Bortolotti per rendersene conto, ma anche i libri di Valerio Evangelisti o quelli di Antoine Volodine in Francia, senza ovviamente citare i maestri del genere, come Dick, che sono in realtà già degli eretici, rispetto alla fantascienza come genere codificato nell’epoca in cui hanno iniziato a scrivere.
Il potere e la visione: Andrea Inglese, Ollivud, Edizioni Prufrock spa, 2018
